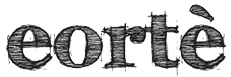Mentre questo lungo tempo di convivenza familiare forzata non è ancora al suo epilogo, tutti noi abbiamo attraversato finora, dentro la nostra navicella spaziale domestica, tutta l’intimità familiare mai osata, l’ineluttabile esplosione della primavera disabitata dalle voci, la Quaresima più incredibile mai vissuta e soprattutto la Pasqua più desiderosa di Resurrezione: giunti ora a questo luogo indefinito e intermedio del nostro viaggio, la certezza di essere stati visitati da un Risorto che sceglie ancora gli affetti deboli di questo mondo e non si stanca della fragilissima bellezza che abita l’uomo, deve interrogare decisamente me (e chiunque altro) sul senso profondo di questo tempo.
Mentre questo lungo tempo di convivenza familiare forzata non è ancora al suo epilogo, tutti noi abbiamo attraversato finora, dentro la nostra navicella spaziale domestica, tutta l’intimità familiare mai osata, l’ineluttabile esplosione della primavera disabitata dalle voci, la Quaresima più incredibile mai vissuta e soprattutto la Pasqua più desiderosa di Resurrezione: giunti ora a questo luogo indefinito e intermedio del nostro viaggio, la certezza di essere stati visitati da un Risorto che sceglie ancora gli affetti deboli di questo mondo e non si stanca della fragilissima bellezza che abita l’uomo, deve interrogare decisamente me (e chiunque altro) sul senso profondo di questo tempo.
Dal mio osservatorio privilegiato di medico (ma non posso che condividere questo sguardo con qualsiasi grado di operatore della sanità che tiene in vita un ospedale e tutta la società civile impegnata sul fronte della cura), quale testimone di infiniti processi di morte, di rinascita, di percorsi di crescita e storie di riscatto, devo assolutamente mettermi in cammino per tentare di collocare il vissuto densissimo e profondo di questa drammatica democratica pandemia senza confini dentro un senso o, almeno, dentro qualche domanda che sposti la mia persona ad un livello umano e spirituale diverso da me (e da noi) prima del virus.
Il primo livello di coscienza raggiunto non può che essere la constatazione che il virus ci ha costretto a rinunciare a due momenti costitutivi del nostro vivere civile, cioè l’accompagnamento alla morte e il rito funebre: il morire isolati non ci ha negato solo il funerale, ma anche i saluti, quella prossimità degli affetti, quell’accompagnamento così importante sia per chi lascia ma ancor più per chi resta. Questo è il contrario di ciò che è umanamente sano, perché la socializzazione del lutto è uno strumento fondamentale da utilizzare per poterlo attraversare. Da subito questo isolamento dagli affetti dei morenti ha caricato noi operatori della sanità del peso maggiore nel complesso corteo di nuovi doveri a cui tutti siamo stati chiamati a sopperire, quello che, insieme alla poca conoscenza scientifica del nostro nemico, ci ha messo più in crisi, perché sentivamo che, se potevamo sopportare il limite dell’isolamento e quello della necessità di essere sepolti quasi da soli, non si potesse però dire davvero per nessuno che si moriva anche da soli, senza un gesto di cura o un saluto, almeno il nostro. Ora, a fronte di questa esperienza così tristemente condivisa, credo sia necessario riconsiderare il nostro rapporto con il pensiero della morte, qui da noi così generalmente occultato e che, a differenza di altri popoli, tendiamo ad evitare ed allontanare da noi, perché ne siamo impreparati, come Paese, cultura e spiritualità.
Allo stesso modo, un altro livello di sollecitazione ci viene dalla necessità come operatori di essere quasi completamente nascosti dai dispositivi di protezione individuale, che accentuano ulteriormente l’isolamento sensoriale tra medici, infermieri, malati: dietro agli occhiali solo gli occhi sono scoperti e, mentre all’inizio dovevamo scrivere i nostri nomi sulle tute per farci riconoscere, non solo dagli ammalati, ma anche dai colleghi di una vita, pian piano abbiamo affinato la capacità di riconoscerci solo dagli occhi, perché anche un sorriso nascosto si vede dagli occhi.
Approfittiamo di questo tempo per imparare a guardare, a guardarci di più negli occhi anche dopo, a respirare, ad annusare cose, vita e profumo delle persone che abbiamo vicino.
Poi c’è l’aspetto forse più significativo che ci ha suggerito, anzi, quasi gridato questo tempo così forzatamente portato alla possibilità della introspezione, a scendere dal mondo per scendere dentro noi: riappropriarsi di una visione che in questo tempo pasquale e di quarantene e Quaresima davvero sa di Resurrezione, cioè quella che ha a che fare con la riscoperta di una modalità comunitaria e non individualistica della esistenza, che sa di condivisione, di stare in contatto con tutta la comunità dei viventi più che con se stessi, coinvolgendoci nella vita e nel cammino degli altri, specialmente i più deboli, per rigenerare e ricostituire una comunità civile apparentemente persa, perché il bene comune è la forma migliore per tutelare ogni individuo ed il modo più nobile di esprimerlo e per uscire da ogni crisi.
Questa crisi pandemica planetaria senza confini e senza distinzioni ci deve insegnare che fragile è la condizione umana, e non dobbiamo temere di essere fragili, perché fragile è il nostro modo di stare nel mondo e fragile è la nostra vita mortale: solo prendere coscienza delle nostre fragilità ci rende forti. Solo una società forte accoglie e riconosce la fragilità, perché chi non riconosce la propria fragilità difficilmente accoglierà quella degli altri.
L’augurio che possiamo farci ritornando presto alle nostre relazioni umane fatte di abbracci e cura, è di non perdere il desiderio ora così forte di incontrarsi e sognare, per ricominciare a progettare, non accontentandoci della nostra vita, della nostra felicità, se non ha dentro anche quella degli altri e la responsabilità del bene comune, alleggerendoci di tutte le nostre costrizioni, per essere più leggeri e capaci di immaginazione, che è insieme la prima forma di futuro ed uno dei volti di Dio.
Marcello